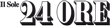Lavoro e professione
Perché la "categoria speciale" per i dirigenti medici
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24

Anche nel corso dell’ultimo sciopero dei medici del 5 dicembre si è riproposta la richiesta di attribuire a essi le condizioni previste per le così dette "categorie speciali".
Per "categoria speciale" si deve intendere la definizione di elevate professionalità cui l’ordinamento riserva determinati incarichi apicali nell’organizzazione statale. L’importanza della categoria è garanzia implicita del possesso dell’ elevata professionalità
Il rapporto di pubblico impiego è definito dunque "rapporto speciale", la cui giustificazione è condivisibile quando ai pubblici dipendenti siano attribuite funzioni pubbliche, con la conseguenza che in vista di tali funzioni è necessario assicurare l’imparzialità dell’amministrazione (come affermato dall’art. 97, co. 2, Cost.) ovvero garantire, in modo più forte di un qualsiasi contratto, lo status del dipendente pubblico.
Categorie Speciali
Il magistrato, come dice la Costituzione, è titolare di un ufficio pubblico. È quindi un organo autonomo e non condizionato dal potere legislativo o da quello esecutivo. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Per il docente universitario il rapporto pubblicistico è conservato per i tratti garantistici : è giustificato dall’esigenza di tutelare i valori costituzionali del pluralismo culturale e della libertà di ricerca scientifica e di insegnamento.
La scienza assume un ruolo centrale tra i valori tutelati dalla Costituzione italiana. Questa garantisce la libertà dell’arte e della scienza, e dei loro rispettivi insegnamenti, in quanto strumentali alla crescita culturale e al progresso dell’umanità. Nell’ordinamento viene riconosciuta la necessità di fornire adeguate tutele e garanzie alla ricerca scientifica, che si rafforza in quanto la libertà di ricerca scientifica risulta spesso strumentale all’esercizio di un diritto fondamentale come quello alla salute (art. 32 Cost.) – intesa sia nella sua dimensione individuale sia in quella collettiva – e al connesso diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario.
Il settore sanitario rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama delle pubbliche amministrazioni, sia perché dominato da un quadro normativo che presenta non pochi profili di specialità, sia per la qualificazione delle Aziende sanitarie locali come aziende in possesso, da un lato, della personalità giuridica di diritto pubblico e, dall’altro, di una vera e propria autonomia imprenditoriale.
Gli operatori sanitari agiscono sul terreno estremamente sensibile dei diritti sociali costituzionalmente garantiti che richiedono inderogabilmente azioni positive da parte dei pubblici poteri per la loro effettiva soddisfazione, in favore di una collettività che non può essere ristretta ai possessori dello status di cittadini.
La disciplina di carattere generale della dirigenza del comparto sanitario si rinviene, anzitutto, nel D.lgs. n. 165 del 2001 (T.U. sul pubblico impiego), che ha esteso la disciplina privatistica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il citato T.U., all’art. 1, comma 2, chiarisce che, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ricondurre anche le "aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Il successivo art. 26, inoltre, nel regolamentare l’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria, menziona espressamente, all’articolo 15 e seguenti, il D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", come normativa speciale alla quale fare riferimento per l’ordinamento della dirigenza del Servizio sanitario.
La dirigenza sanitaria, in base a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 502 del 1992 "è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali".
Nell’organizzazione sanitaria, il principio di distinzione fra attività di indirizzo e attività gestionale si realizza nella dinamica dei rapporti fra governo regionale e direzione delle aziende sanitarie e si basa sulla natura strumentale dell’azienda sanitaria rispetto al raggiungimento degli obiettivi di salute, individuati, per l’appunto, dalla Regione e posti in essere dall’azienda stessa.
I dirigenti medici svolgono anzitutto un’attività professionale alla quale può affiancarsi un incarico gestionale in senso proprio. Con particolare riguardo ai medici, inoltre, occorre sottolineare che la qualifica dirigenziale è automaticamente connessa alla loro professionalità. Ne deriva che, tutti i medici dipendenti delle aziende sanitarie sono inquadrati come dirigenti a prescindere dallo svolgimento di incarichi di direzione di strutture.
I dirigenti medici oltre alle funzioni afferenti le competenze professionali specifiche , svolgono anche funzioni di direzione e organizzazione della struttura, mediante atti di organizzazione del personale necessari per il corretto espletamento del servizio.
La sfera delle responsabilità imputabili al dirigente medico è connessa, in primo luogo, al tema della responsabilità disciplinare per il mancato rispetto delle regole poste a presidio dell’attività svolta dovuto a un comportamento negligente e colposo. In secondo luogo si pone il tema della responsabilità dirigenziale propriamente detta, che attiene al mancato raggiungimento dei risultati da parte del dirigente. Infine, si collega il tema della responsabilità amministrativa che si riferisce alle conseguenze dannose delle scelte effettuate dal dirigente per il patrimonio della pubblica amministrazione.
La responsabilità del dirigente medico rappresenta un ulteriore profilo sotto il quale il dirigente del comparto sanitario può essere chiamato a rispondere previo espletamento delle opportune procedure di valutazione. Si tratta di una tipologia di responsabilità che attiene ai risultati complessivamente prodotti dall’organizzazione cui il dirigente è preposto.
Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, siano essi relativi a strutture semplici ovvero complesse, deve avvenire nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge. E’ evidente che il mancato rispetto delle procedure determina l’illegittimità del provvedimento di nomina.
In questi casi eventuali illegittimità possono essere fatte valere dagli interessati con la proposizione, previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, di un ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Al Giudice Ordinario, infatti, è rimessa, ai sensi dell’art.63 del d.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.
Qualora nelle questioni inerenti conferimento e revoca di incarichi dirigenziali vengano in rilievo provvedimenti amministrativi incidenti sulla stesa struttura organizzativa dell’azienda, cd. provvedimenti di macro organizzazione, che siano tali da incidere, ledendole, sulle posizioni soggettive dell’interessato, tali provvedimenti dovranno essere oggetto di impugnativa giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo.
Infine, non è certo privo di rilievo che i professori universitari siano stati, unitamente ai magistrati, individuati tra le categorie di pubblici dipendenti che possono essere chiamati alle funzioni di giudice costituzionale o di componente del Consiglio Superiore della Magistratura (artt. 104 e 135 Cost.), ovvero nominati all’ufficio di consigliere di cassazione per meriti insigni (art. 106, comma 3, Cost.): e ciò non soltanto per specificità culturali (i meriti scientifici possono trovare adeguato sbocco nella nomina dei sanatori a vita, art. 59 Cost.), ma principalmente per la posizione costituzionale di indipendenza dal potere d’indirizzo politico che contraddistingue, nel suo complesso, l’impostazione del trattamento professionale, giustificando, del pari, il regime pubblicistico del relativo stato giuridico.
Aspetti economici e contrattuali Legge 240/2010
Per altro verso, attesa la distinzione solo per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, Cost.), è invalso, per i magistrati, un sistema di progressione economica con scatti e adeguamenti automatici sulla base della professionalità e dell’esperienza acquisite, ossia dall’anzianità senza demerito. Il meccanismo prescinde, dunque, dalla qualifica rivestita e, in attuazione delle garanzie costituzionali, tende a evitare che i magistrati siano tentati ad avanzare periodiche rivendicazioni su questioni afferenti al loro status e concernenti, in particolare, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico .
Per il personale docente delle Università, invece, la progressione alla successiva classe stipendiale è subordinata a una espressa richiesta e alla contestuale presentazione di una relazione sul complesso delle attività (didattiche, di ricerca e gestionali) svolte nel biennio e, quindi, all’esito positivo di una valutazione, ancora una volta decentrata, di competenza delle Università di appartenenza, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti. In particolare, la disciplina, rimodellata dall’art. 6, comma 14, della l. n. 240 del 2010115, ha innovato rispetto alla previgente (di cui agli artt. 36 e 38 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), che si articolava in scatti biennali automatici del 2,50 per cento, calcolati sulla classe di stipendio finale
© RIPRODUZIONE RISERVATA