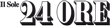Medicina e ricerca
Le terapie avanzate in cardiologia non sono più un sogno irrealizzabile
di Giulio Pompilio*
24 Esclusivo per Sanità24

Non più di due decadi fa era convinzione comune in cardiologia che il cuore fosse in grado di rispondere a stimoli patogeni aumentando la sua massa contrattile attraverso meccanismi indipendenti dalla divisione cellulare. Come è accaduto per molti “dogmi” scientifici, questa concezione “statica” del cuore non ha resistito a scoperte che ne hanno provato l’incompletezza. Oggi sappiamo che il cuore ha una sua capacità rigenerativa intrinseca, seppure molto limitata, pari all’incirca al 1% annuo del totale delle sue cellule, che si riduce con il progredire con l’età. Una capacità auto-rigenerativa chiaramente insufficiente, da qui le ragioni delle vecchie convinzioni, a far fronte a malattie cardiache degenerative, come l’infarto o l’insufficienza cardiaca. Tuttavia, questa scoperta ha lo stesso rivoluzionato la biologia del cuore ed ha rappresentato, in ambito di ricerca, una fondamentale rivoluzione culturale, che ha dato impulso alla cosiddetta cardiologia rigenerativa, nata con il grande obbiettivo di potenziare la rigenerazione cardiaca nel momento in cui il cuore si ammala, dato che, lasciato a sé stesso, non è in grado di farlo. La cardiologia ha così fatto ingresso nel mondo delle terapie biologiche, ed in particolare delle nuove terapie con medicinali avanzati (ATMP).
Va detto subito che il sogno di ricostruire il cuore malato per il momento rimane tale, malgrado moltissimi passi siano stati compiuti nella direzione della comprensione dei meccanismi molecolari che sottendono alla rigenerazione cardiaca, e malgrado alcuni tentativi siano già stati messi in opera in studi precoci sull’uomo, soprattutto attraverso approcci di terapia cellulare, che però al momento non hanno dato i frutti sperati. Sul fronte della ricostruzione della massa contrattile, il futuro sembra correre in due direzioni: la prima porta a cercare di potenziare le capacità autorigeneranti del cuore, accendendo le chiavi molecolari giuste, per esempio somministrando farmaci biologici (terapia genica, RNA) capaci di spingere le cellule cardiache già presenti a proliferare; la seconda è impiantare cellule molto più potenti di quelle impiegate finora, derivate dalle cellule pluripotenti indotte (IPS). Si tratta di cellule adulte (somatiche) riprogrammate, in cui cioè l’orologio biologico è stato riportato indietro, fino allo stato embrionale, per derivarne cellule cardiache (cardiomiociti) che, tornate giovani, avranno acquisito maggiore efficienza. I cardiomiociti derivati da IPS vengono inseriti tramite iniezione nel cuore danneggiato del paziente. Ipotesi scientifiche promettenti, al momento ancora non testate sull’uomo.
Allo stato attuale, siamo più bravi ad interagire terapeuticamente con i vasi sanguigni cardiaci. La natura ha già previsto che in alcuni casi di malattia coronarica severa, la mancanza di ossigeno indotta dalla patologia induca la formazione nel tessuto miocardico di piccoli vasi vicarianti. Da anni la ricerca sta lavorando a soluzioni terapeutiche che potenzino la capacità naturale del cuore di ricostruire almeno parzialmente la sua microcircolazione. Si tratta di un campo di ricerca che prende il nome di “angiogenesi terapeutica”. Cellule progenitrici con specifiche abilità di promuovere il microcircolo agendo come delle micropompe biologiche in grado di rilasciare fattori “vitali” che aumentano il benessere della componente vascolare vengono iniettate nelle zone sofferenti del cuore di pazienti con forme molto gravi di cardiopatia ischemica. In alcuni centri specializzati, come il Centro Cardiologico Monzino IRCCS in Italia, sono state avviate delle sperimentazioni con prodotti di terapia cellulare nell’ischemia cronica intrattabile, una condizione in cui la mancanza cronica di ossigeno al cuore provoca un dolore appunto refrattario ai farmaci, non curabile con le terapie convenzionali, ma che sembra rispondere bene a terapie cellulari per la rigenerazione del microcircolo. I dati di alcuni studi che abbiamo condotto hanno dimostrato che in molti pazienti la terapia migliora l’apporto di ossigeno al cuore.
Come detto in precedenza, la terapia genica e le nuove terapie a RNA rappresentano un altro possibile futuro modello terapeutico di rigenerazione cardiaca, che è in fase di sperimentazione, sia per condizioni croniche, come l’insufficienza cardiaca ischemica, che per malattie cardiache genetiche. In sintesi si tratta di introdurre nel cuore il materiale genico attraverso vettori virali o nanoparticelle con tropismo cardiaco, cioè prevalentemente orientate a raggiungere le cellule cardiache. Di queste terapie potranno per esempio beneficiare pazienti portatori di malattie genetiche oggi incurabili, come la cardiomiopatia aritmogena, il QT lungo, le tachicardie ventricolari catecolaminergiche. Per alcune di esse sono in corso studi clinici internazionali, volti a testarne il potenziale beneficio. Anche sul versante della ricostruzione del microcircolo, vi sono analogamente studi in corso, sia di terapia genica che con RNA, nei quali l’obbiettivo è quello di “insegnare” alle cellule cardiache residenti a produrre quei fattori critici che inducono nel tessuto sofferente l’angiogenesi terapeutica. Un altro modello affascinate di terapia genica, seppur ancora futuribile per l’applicazione in cardiologia, è rappresentato dalle cosiddette cellule CAR-T, cioè linfociti ingegnerizzati che esprimono un recettore che va a intercettare/colpire specifici bersagli. Queste terapie sono in fase di forte sviluppo nel settore oncologico, e rappresentano oggi una concreta speranza di cura per pazienti ieri incurabili. In cardiologia esistono interessanti dati preliminari circa l’utilizzo delle CAR-T per limitare la fibrosi, la degenerazione del tessuto cardiaco alla base di diverse patologie associate allo scompenso.
In conclusione, la cardiologia, a differenza di altri settori della medicina, non ha ancora beneficiato delle opportunità di cura offerte dalle terapie biologiche avanzate. Vi sono tuttavia indizi concreti che esse rappresentino una speranza concreta anche per i pazienti portatori di patologie cardiache oggi non curabili.
*Direttore Scientifico
Centro Cardiologico Monzino IRCCS
© RIPRODUZIONE RISERVATA