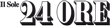Aziende e regioni
Assistenza sociale: l’art 38 Costituzione da sempre nell’ombra ed esposto ad abusi deve spiccare il volo. Proposta per dare prestazioni appropriate e sostenibili
di Ettore Jorio
24 Esclusivo per Sanità24

Uno dei temi più trascurati riguarda l’attuazione dell’art. 38, perché letto solo in pendant con l’art. 32 nel più generico tema della tutela del diritto alla salute. Quell’articolo della Carta che disegna i diritti attraverso i quali i bisognosi percepiscono l’assistenza sociale.
Una materia, quest’ultima, che vive due diversi trattamenti. Uno, quello più sostanziale, avvertito dalla popolazione in difficoltà nei suoi diversi aspetti: inabilità al lavoro, assenza di mezzi necessari per vivere, afflitti da minorazioni, disoccupazione involontaria, infortuni, malattie invalidanti e vecchiaia. L’altro afferente al suo confinamento tra le materie residuali dalla revisione costituzionale del 2001. Con questo, è stata esclusa dalla competenza concorrente e, di conseguenza lasciata in mano alle Regioni che l’hanno maltrattata per lo più facendo riferimento esclusivo, nel loro agire legislativo, alla legge 328/2000. Una legge, approvata prima della anzidetta revisione e vecchia di un quarto di secolo, da ritenersi, da una parte, obsoleta quanto a ratio ispiratrice e inadeguata alle soluzioni, considerata l’evoluzione della persona nel tempo, sia in termini di bisogno che di esigenze dei servizi da rendere.
Un articolo della Costituzione attuato così così
In una tale condizione di inerzia attuativa del principio costituzionale si sono insediate soluzioni di facciata, spesso tollerate e financo mediate dalla politica a uso clientelare. Da qui, l’esplosione del ricorso per 45 anni circa alla previdenza cosiddetta non contributiva (pensioni di invalidità) propedeutica all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento (1980) ai riconosciuti invalidi civili totali. Due misure, molto spesso abusate, che hanno di fatto assicurato in alcuni territori condizioni di vita alle persone e ripagamenti elettorali ai corrispondenti facilitatori. A tutto questo sono andati ovviamente ad aggiungersi i benefici, intesi come garanzie economiche e facilitazioni, della n. 104/1992, recante “La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Una esperienza - fatta di tre strumenti non infrequentemente goduti borderline (pensione di invalidità civile al 100%, indennità di accompagnamento, facilitazioni familiari ex legge 104/1992, che hanno contribuito non poco a svuotare di personale i siti più sensibili di servizi pubblici) - che è stata valutata dalla politica in modo segnatamente produttivo in termini di storica raccolta del consenso.
Si è giunti al dispendioso e non risolutivo
Tant’è che in alcune regioni la presenza dei beneficiari è divenuta enorme, fino a raggiungere cifre nelle Isole (dati Istat 2021) per un valore medio del 6.5% della popolazione, così come in alcune regioni punte più elevate del tipo l’Umbria e la Sardegna (rispettivamente, il 6.9% e il 7.9% della popolazione), con a seguire la Campania, la Calabria e via dicendo, con il Mezzogiorno fagocitante. In un report dell’Istat riferito al 2016, vennero fuori dei dati allarmanti: gli invalidi di Oristano e Lecce (ove venivano erogate 117mila pensioni su una popolazione provinciale complessiva di 804mila abitanti) erano più del triplo di quelli di Treviso e Milano; in Sardegna in sei province su otto si superava il 10% (ovverosia una pensione di invalidità erogata ogni 10 abitanti); in Calabria la percentuale oltrepassava l’11%; a Messina 82mila assegni su 640mila residenti; in Basilicata, record a Potenza che arrivava alla percentuale dell’11,6% e Matera che si fermava al 7,1% (si veda articolo di A. Giannotti su IlSole24Ore del 23 novembre 2018).
Da qui, il passo è stato facile per la introduzione del reddito di cittadinanza, quale misura di sostegno e di contrasto alla povertà che altro non è - unitamente alla cosiddetta pensione di cittadinanza destinata alle famiglia in possesso di determinati requisiti (senza reddito purché di età superiore ai 67 anni ovvero inferiore ma in condizione di disabilità grave o non autosufficienti) - che una misura previdenziale non contributiva, affine alla ex pensione sociale tradotta dal 1996 in assegno, per l’appunto, sociale. Quella prestazione economico-assistenziale prevista in favore di chi, seppure non avendo mai lavorato e dunque versato contributi previdenziali, ha maturato la soglia anagrafica di cittadino ultra sessantasettenne.
L’unica differenza tra le due diverse gratificazioni economiche è che la percezione del reddito di cittadinanza, diversamente dall’assegno sociale/pensione di cittadinanza, non è da considerarsi a tempo indeterminato, in quanto finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro o all’inclusione sociale, raggiunti i quali pertanto viene a cessarne il relativo diritto.
Il bisogno di ricostruire l’assistenza full time...
A ben vedere, riprendendo il tema delle garanzie costituzionali scandite nell’art. 38 della Carta, ci si accorge che - nonostante trascorsi ottant’anni dalla sua previsione - è stato realizzato ben poco in favore dei suoi reali destinatari.
A nulla sono serviti gli interventi di previdenza non contributiva e di assistenza general-generica, dall’effetto placebo per il versante del beneficiario e clientelare per il facilitatore.
Il problema dell’assistenza sociale è cosa seria e come tale va trattata, stando bene attenti a non cadere in facili equivoci e arrivare alle errate conclusioni, cui in tanti pervengono nel delineare l’esigenza della cosiddetta assistenza integrata sociosanitaria. Sono rare da assumere le traduzioni ben fatte del cosiddetto Liveas, introdotto nei Lea con il Dpcm del 12 gennaio 2017, e sulle sue modalità erogative, anche in termini di corretta individuazione delle istituzioni competenti a rendere esigibili i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria.
Oggi il tema del contenuto dei Lea onnicomprensivi e la loro sostenibilità è di grande attualità, atteso il lavoro ancora in corso del Clep, presieduto da Sabino Cassese, e l’impegno del Governo a emanare i conseguenti decreti legislativi applicativi, finalmente, del federalismo fiscale.
Il punto clou sarà quello di valutare bene le conseguenze del regionalismo differenziato, in termini di ipotetica rivendicazione delle Regioni ad accedere alle competenze legislative complessive in materia di tutela della salute. Ciò in quanto si dovranno, in proposito, individuare bene le occasioni per riconoscere all’assistenza sociale la giusta dimensione e il corretto spessore erogativo, da garantire sia in fase di prevenzione, di cura e, soprattutto, di riabilitazione. Insomma, una prestazione sociale strumentale a evitare lo stato di malattia, ad assistere l’affetto da patologia e a contribuire, ex post, a riabilitare il riabilitabile ovvero ad assistere l’inabile.
...facendo peraltro economia intelligente
A un problema simile potrebbe contrapporsi la previsione - utile a che il nonno beneficiario diventi anche il destinatario certo delle previdenze economiche, spesso in uso dei nipoti, tradotte in servizi reali - di retribuire gli esistenti benefit assistenziali/previdenziali per invalidi al 100% con voucher spendibili, in primis, direttamente presso il Ssn così come a titolo di contribuzione, per esempio, per il badantato (retribuzioni caregiver).
Un modo per realizzare una sorta di economia circolare tra il sistema previdenziale e quello afferente all’assistenza sociosanitaria, ma soprattutto per garantire al bisognoso una assistenza a 360°.
© RIPRODUZIONE RISERVATA