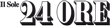Aziende e regioni
Un cambio di prospettiva sulla salute e il benessere della popolazione anziana
di Duilio Carusi *
24 Esclusivo per Sanità24

La tendenza all’invecchiamento della popolazione, la crescente fragilità e multi-cronicità degli anziani, il mutato concetto di benessere e di qualità della vita in età senile, stanno comportando inevitabili cambiamenti, nella figura e nel ruolo dei caregiver, nella riorganizzazione degli spazi abitativi e urbani, nella promozione dell’invecchiamento attivo e nell’evoluzione dell’interfaccia con il sistema salute da parte degli anziani e dei loro familiari.
Nell’arco di pochi decenni si sono originati nuovi tempi di vita ed una ecologia inedita della popolazione anziana che richiedono nuove strategie per la salute ed il benessere: queste strategie sono sempre più affidate non ai soli strumenti economici e tecnologici, ma anche grandemente alla solidarietà sociale.
L’implementazione di un nuovo trasferimento culturale sul tema dell’invecchiamento è realizzabile tramite un’estensione del sistema salute a nuove componenti e conoscenze, al fine di rispettare l’interdipendenza di tutti quei fenomeni sociali, economici ed ambientali che condizionano la salute e il benessere della popolazione.
Per questo l’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza studia l’andamento della Vicinanza della salute, un concetto inedito che integra la relazione, nello spazio e nel tempo, che intercorre tra la persona ed il bene salute con l’effettiva capacità di fruire della salute stessa, osservando il verificarsi delle cosiddette “condizioni abilitanti”. Si passa dalla sola analisi dei servizi offerti al cittadino in tempi e distanze più o meno congrui, al monitoraggio di elementi necessari all’attuazione della salute: vengono quindi analizzati la condizione e la percezione dei luoghi di vita e dell’abitazione, le competenze nell’uso degli strumenti digitali, l’accesso ai sistemi di welfare, l’equità nell’accesso alle infrastrutture, la disponibilità economica degli individui.
Questa nuova prospettiva di analisi risulta sempre più attuale se consideriamo che la transizione demografica ha portato non solo ad un aumento dell’aspettativa di vita, ma ad un aumento dell’aspettativa di vita in salute. Il fenomeno porta con sè una rivoluzione nella interpretazione e nello sviluppo degli anni di vita da trascorrere dopo il raggiungimento dei 65 anni, soglia che storicamente (e forse ormai anacronisticamente) ha da sempre sancito l’ingresso nella “terza età”.
A differenza di un recente passato, oggi lo stato di salute generale della popolazione che si accinge ad entrare nella terza età, presenta, infatti, caratteristiche di salute, bisogni, aspettative e capacità molto più simili ad una popolazione giovane, tanto da aver portato l’Osservatorio a coniare il termine di “quasi” terza età: con lo slittamento degli stadi più severi di fragilità verso i grandi anziani, lo status di “anziano” sembrerebbe oggi più consono ad una popolazione ultrasettantacinquenne.
Questa estensione della vita attiva e in buona salute, legata indissolubilmente a modelli culturali che promuovono la diffusione di un “giovane anziano”, pur nel loro evidente ossimoro, evidenziano la necessità di una nuova lettura dello stato di salute e benessere della popolazione over 65 al fine di non incorrere in facili ottimismi.
Quello che emerge dal recente studio sulla Vicinanza della salute per la popolazione over 65 condotto da Fondazione Visentini e che sarà presentato presso l’Università Luiss Guido Carli il prossimo 28 maggio, è infatti un quadro che accende diversi campanelli d’allarme.
La rilevazione 2023 dell’Indice di Vicinanza della salute (IVS) over 65 fa emergere un andamento costantemente peggiore per la popolazione over 65 rispetto alla popolazione generale italiana, e i segni negativi sono concentrati soprattutto sulle componenti relative alla sfera individuale e delle relazioni sociali.
Il primo elemento di allarme, e probabilmente il più problematico, è legato al fenomeno dell’isolamento che, complice la crescente disgregazione delle reti sociali e familiari, attanaglia maggiormente la popolazione anziana rispetto alla popolazione italiana nel suo complesso. L’isolamento, infatti, registrando 9 punti nella popolazione anziana contro i 91 punti registrati nella popolazione totale, evidenzia la prima priorità da affrontare per migliorare la salute degli anziani portando l’attenzione sulla sfera individuale extrasanitaria.
Correda questo dato la rilevazione dedicata alla mental health, che fa segnare un differenziale di oltre 52 punti fra la salute mentale degli anziani e quella della popolazione generale, evidenziando anche su questo fondamentale tema l’urgenza di intervenire per ridurre il più possibile il gap esistente.
Un’altra componente di rischio per la salute della popolazione anziana è costituita dal basso livello di literacy, ovvero l’alfabetizzazione, nello specifico sanitaria, che rappresenta una delle principali condizioni abilitanti per la salute. Il livello delle competenze digitali avanzate dell’anziano in Italia risulta molto basso ed al di sotto della media europea: la rilevazione dell’Osservatorio sulla literacy fa registrare un grande gap a svantaggio della popolazione over 65, con soli 20 punti rispetto ai 96 della popolazione totale, con importanti conseguenze sulla capacità di poter fruire dei nuovi servizi digitali al cittadino.
Un dato fortunatamente in controtendenza è, invece, quello che emerge dalla rilevazione della coesione sociale, uno dei pochi ambiti dove si rileva per il 2022 un valore in ripresa dopo la caduta libera prodotta dalle misure di contenimento per la pandemia: stando ai numeri, la partecipazione sociale e le attività di volontariato sono in ripresa, portando il dominio “Coesione sociale” al massimo storico di 66 punti, dopo il crollo a 45 punti registrato nel 2020.
I dati rilevati riportano l’attenzione sulla componente individuale e delle relazioni sociali come chiave fondamentale per la salute ed il benessere della popolazione over 65, evidenziando ancora una volta come sia necessario introdurre ed armonizzare queste nuove istanze in un’unica pianificazione nazionale per la salute che tenga conto oltre che della componente sanitaria anche delle dimensioni extrasanitarie e dei determinanti sociali per la salute.
* Adjunct Professor Luiss Business School, Coordinatore dell’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza della Fondazione Bruno Visentini
© RIPRODUZIONE RISERVATA